
Una giovane e spaurita dama di compagnia s’imbatte in Costa Azzurra, dove si trova al seguito della dispotica madama che l’ha assoldata, in un fascinoso nobiluomo e lo sposa dopo pochi giorni appena di frettolosa conoscenza. Lui la conduce con sé a Manderley, la fiabesca dimora di famiglia citata in tutte le guide turistiche, ma una volta là il complesso d’inferiorità e la sensazione di non essere all’altezza della giovane sposa si acuiscono a causa della persistenza, tra le mura del castello e nel ricordo della società dei dintorni, del fantasma della prima moglie di lui, l’affascinante e bellissima Rebecca, morta in un incidente in mare appena un anno prima…
Questo l’intreccio di Rebecca la prima moglie, il capolavoro di Daphne Du Maurier del 1938 da cui nel ’40 Alfred Hitchcock trarrà l’omonimo film, complessivamente fedele all’originale salvo due o tre particolari d’importanza variabile imposti dal Codice Hays o da personali scelte registiche.
Ad esempio nelle modalità della morte di Rebecca, con lui che nel film, appunto in osservanza del Codice, non le spara, ma la spinge al culmine d’un litigio facendola cadere su una carrucola, e i biondi capelli ondulati e spesso un po’ scomposti della protagonista – un’efficace Joan Fontaine, perfetta nel ruolo dell’ingenua, lo stesso che qualche anno più tardi interpreterà ne Il sospetto – che rendono incongruo il riferimento al costume da Giovanna d’Arco per il ballo in maschera a Manderley (quel disegno che lei scarabocchia mentre cerca di farsi venire un’idea).
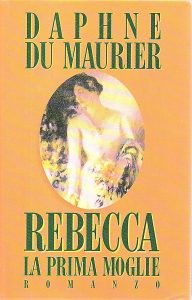 Nel libro si fa invece ripetuto riferimento ai capelli troppo lisci della nuova moglie – pettinata evidentemente alla maschietta com’era di moda all’epoca – e c’è pure l’esplicito suggerimento dato alla giovane donna da Frank Crawley, collaboratore e amico del marito Maxim (“Con i vostri capelli fareste una magnifica Giovanna d’Arco…”), anticipato dalla battuta della cognata Beatrice (una segaligna Gladys Cooper) durante la prima presa di contatto tra le due: “Avete mai pensato d’arricciarvi i capelli? Sono un po’ troppo lisci, così… Non debbono essere una bellezza, sotto il cappello. Non mi è mai piaciuta quella pettinatura alla Giovanna d’Arco, o come la chiamano…”.
Nel libro si fa invece ripetuto riferimento ai capelli troppo lisci della nuova moglie – pettinata evidentemente alla maschietta com’era di moda all’epoca – e c’è pure l’esplicito suggerimento dato alla giovane donna da Frank Crawley, collaboratore e amico del marito Maxim (“Con i vostri capelli fareste una magnifica Giovanna d’Arco…”), anticipato dalla battuta della cognata Beatrice (una segaligna Gladys Cooper) durante la prima presa di contatto tra le due: “Avete mai pensato d’arricciarvi i capelli? Sono un po’ troppo lisci, così… Non debbono essere una bellezza, sotto il cappello. Non mi è mai piaciuta quella pettinatura alla Giovanna d’Arco, o come la chiamano…”.
Sullo schermo Crawley, braccio destro di Giorgio Fortebraccio Massimiliano (Maxim) de Winter (un azzimato e tenebroso Laurence Olivier) è Reginald Denny: un Frank Crawley meno impacciato rispetto al personaggio del libro così come necessariamente attenuata risulta la sua complicità con la protagonista, sostituita dal rapporto da uomo a uomo con de Winter.
Protagonista, tra parentesi, di cui nel film come nel libro non viene mai pronunciato il nome: tratto, questo, che rappresentò un problema in fase di sceneggiatura e che può accomunare la giovane signora de Winter all’istitutrice di Giro di vite (il romanzo di James da cui nel ’61 il regista Jack Clayton trarrà il suo Suspense), pure lei innominata per tutto il romanzo, insieme all’incanto ingenuo suscitato nelle due donne dall’atmosfera fatata delle antiche dimore di famiglia in cui si trovano entrambe catapultate senza troppo preavviso e abbastanza per caso.
Assente nel film è poi l’imbarazzante scena a casa della decrepita nonna dei fratelli de Winter, con la vegliarda che non riesce a capire chi sia la nuova arrivata e continua a invocare stizzosamente l’amata Rebecca: scena di fondamentale importanza nel libro per riacutizzare il senso d’inferiorità della giovane moglie e la sua radicata convinzione che “tutti adoravano Rebecca” e che rappresenterà un significativo sassolino sul sentiero della tormentata spiegazione-confessione di Maxim (“Essa sapeva sempre quel che doveva dire a tutti; era capace d’intonarsi a ogni diverso carattere. Se mai tu l’avessi conosciuta, subito t’avrebbe presa a braccetto e sareste andate insieme a spasso per il giardino, discorrendo di fiori, di musica, di pittura… di quella ch’essa sapeva o supponeva fosse la tua occupazione preferita; e tu saresti rimasta incantata, come tutti quanti… Persino la nonna, che a quei tempi era una donna di gusti difficili, l’ha adorata dal primo momento. ‘Essa ha le tre qualità più importanti per una moglie’ mi disse: ‘razza, cervello e bellezza’… Oh, mio Dio!”).
Tra parentesi, è significativo notare come i tentativi della protagonista di comprendere il comportamento del marito e scoprire le ragioni del suo tormento non abbiano altro effetto che quello d’allontanarlo (Maxim non desidera affatto ricordare ma solo rimuovere quel passato che invece la moglie vorrebbe dissotterrare). Un po’ come nella favola di Amore e Psiche, la curiosità di lei ha come risultato la fuga di lui, seguita da un accidentato percorso di recupero intrapreso ancora una volta dalla metà femminile della coppia, ostacolata da altre figure – e non è un caso, forse, che la nuova moglie appena arrivata a Manderley mandi in frantumi urtandolo goffamente un prezioso Cupido di porcellana appartenuto proprio a Rebecca…
Ancora, dal punto di vista psicanalitico è stato osservato che la protagonista del romanzo compie un percorso di ricerca della propria identità, che conquista faticosamente sottraendosi sia alla dipendenza che alla conflittualità con le altre tre figure femminili, la Van Hopper, la Danvers e la stessa Rebecca, la cui assordante assenza è in realtà una presenza: anche e soprattutto grazie agli innumerevoli oggetti di sua proprietà o a vario titolo a lei riconducibili disseminati ovunque a Manderley come una sorta di maligni aiutanti magici, lesti a riprender vita per rammentare all’intrusa la sua penosa inadeguatezza (il Cupido di porcellana, i fazzoletti cifrati, la carta da lettere intestata, le dediche sui libri con quella calligrafia aguzza…).
E nel film scompare anche la scena tra la protagonista, sconvolta dalla reazione del marito alla vista del costume da gentildonna da lei indossato per il ballo in maschera (lo stesso scelto da Rebecca un anno prima nella medesima occasione, ma la nuova moglie non poteva saperlo: l’idea le è stata suggerita dalla governante di casa, la maligna signora Danvers…), e la benintenzionata Beatrice, che nel libro esorta la cognata in lacrime a “mettersi un bel vestito azzurro” qualsiasi e a scendere al più presto tra gli ospiti che ormai affollano il salone delle feste: con l’altra che ostinatamente rifiuta, incassando l’inespresso biasimo dell’amica e biasimandosi profondamente lei stessa (“Sentivo che col mio rifiuto di scendere a cena m’ero giocata la simpatia ch’ella aveva per me. M’ero dimostrata vile. Ed ella non aveva capito. Ella apparteneva a un’altra razza d’uomini e di donne; erano coraggiose, le donne della sua razza. Se Beatrice fosse stata al posto mio, si sarebbe infilata il vestito da sera, bravamente, e sarebbe scesa ad accogliere i suoi ospiti… Io non ne ero capace. Mi mancava l’orgoglio, mi mancava il coraggio. Ero stata educata male”).
E scompare per conseguenza la scena successiva, con la lenta presa di coscienza di lei e la sua decisione di scendere, dopotutto, tra gli ospiti spacciando la storiella qualsiasi d’un errore della sartoria incaricata di confezionare il costume e affrontando tutta l’interminabile nottata del ballo in maschera, fianco a fianco con l’impietrito consorte che non le rivolge mai la parola: “Non c’era nulla di coraggioso e di bello nel mio gesto, non era che uno sciagurato tributo alle convenzioni. Non volevo che gli invitati credessero ch’io avevo litigato con Maxim. Ero dunque scesa per amor mio, per il mio povero amor proprio…”.
Un tema, questo dell’orgoglio meschino e del terrore del giudizio altrui, che a suo tempo ha avuto un peso cruciale anche nella decisione di Maxim di non rivelare la farsa del proprio matrimonio con Rebecca, sostenendo invece la parte del marito innamorato pur d’evitare lo scandalo e la vergogna d’un divorzio a Manderley: “Essa era certa ch’io avrei sacrificato orgoglio, onore, amor proprio e qualsiasi altro dannato sentimento personale, piuttosto che trovarmi di fronte al nostro piccolo mondo dopo una settimana di matrimonio, e lasciar che trapelassero le cose ch’essa mi aveva detto di sé. Sapeva ch’io non avrei mai tollerato una causa di divorzio, in cui avrei dovuto dar la verità in pasto all’opinione pubblica… Avevo sempre pensato troppo a Manderley… Avevo messo Manderley in primo luogo, avanti a tutto”.
Intermezzo, quello dello scambio tra la protagonista e Beatrice e poi della notte del ballo, che nel film è del tutto assente, il filo degli eventi riannodandosi bruscamente all’alba grigia del mattino successivo, col ritrovamento del panfilo dove la prima moglie è annegata un anno prima rovesciato e incastrato sul fondo della baia; dopo il drammatico confronto tra la giovane donna rintanata nella sua stanza in preda allo shock e una signora Danvers spietatamente insinuante che la incita a saltar giù dalla finestra e a smetterla una buona volta nel tentativo di spuntarla su un’invincibile Rebecca.
Una marmorea Judith Anderson è, appunto, Dennie Danvers, la governante di casa che ha allevato Rebecca fin da bambina nutrendo per lei una devozione fanatica che le vieta, adesso, d’accogliere in modo civile la nuova signora de Winter, spingendola a manovrare nell’ombra per renderle la vita impossibile.
È stato osservato che la Danvers in pratica non muove passo ma scivola silenziosamente sul pavimento a mo’ di fantasma e questo, assieme alla maschera impassibile del volto, contribuisce a renderla spaventosa come i personaggi cattivi delle favole: come, ad esempio, la matrigna o le sorellastre di Cenerentola, fiaba a cui Rebecca è stata accostata tra gli altri dallo stesso Hitchcock.
A me ricorda anche La Bella Addomentata, con tutte le illusioni della protagonista nei primissimi tempi del matrimonio e poi gli abbagli e i malintesi con Maxim a proposito della perfetta unione di lui con Rebecca, sorta di lungo sonno dal quale la confessione di lui la desterà all’improvviso; e ancor più La Bella e la Bestia, con quel castello bello come un sogno e però assorto e bloccato dall’incantesimo di un’oscura presenza (la Danvers, in questo caso; e, ancora, i due fantasmi che si sono impossessati o tentano d’impossessarsi dei piccoli Miles e Flora in Giro di vite/Suspense).
Tra parentesi, mentre nel romanzo del perdurare della Danvers a Manderley pur dopo la morte di Rebecca viene più volte fornita una giustificazione – prima con la necessità di mandare avanti la casa, resa splendida ma complicata dal raffinato buon gusto della prima moglie, poi con la scarsa esperienza della giovane sposa e infine, durante la tempestosa confessione di Maxim, col timore di metter fuori di casa un possibile testimone scomodo… -, nel film l’apparente inamovibilità di questa creatura palesemente ostile alla nuova arrivata appare abbastanza inspiegabile e contribuisce a far sospettare di disattenzione e insensibilità un de Winter fin troppo sbrigativo.
A proposito di sogni il film, fedele all’originale, si apre col sogno della protagonista, tornata come per magia a passeggiare per i viali di Manderley e la Valle delle Farfalle in un’atmosfera da favola gotica che culmina nella visione del castello ormai in rovina. Hitchcock stesso dichiarò che Rebecca era in pratica “la storia d’una casa: si può dire che la casa è uno dei tre personaggi principali del film”.
Un elemento, questo delle case e della loro vincolante personalità e un meccanismo, quello del sogno iniziale della protagonista – che trasporta all’indietro la storia ormai conclusa in un lungo, ininterrotto flashback – che qualche anno dopo verrà ripreso dal Fritz Lang di Dietro la porta chiusa, con la cruciale riflessione d’apertura di lei: “Il modo come è fatta una casa determina ciò che accade in essa…”.
Simile anche la camera matrimoniale-museo, lasciata intatta in Rebecca da una Danvers ossessivamente dedita al ricordo della defunta e trasferita in ogni dettaglio dal protagonista mentalmente instabile nell’ala del palazzo riservata alla propria collezione di stanze in Dietro la porta chiusa (tratto anch’esso da un romanzo, Camera chiusa n. 13 di Rufus King).
George Sanders è un ottimo Jack Favell, l’ambiguo cugino/amante di Rebecca, e uno stralunato Leonard Carey è Ben, il vagabondo non del tutto compos mentis che la protagonista incontra per caso lungo la spiaggia e che alla nuova, gentile e compassionevole signora de Winter farà dono del suo silenzio – lui che, la notte in cui Rebecca è scomparsa in mare, era nei paraggi e ha visto tutto -, contribuendo a salvarne dalla forca l’amato Maxim.
E Florence Bates è una gustosamente antipatica signora Van Hopper, intrigante e impiastricciata come si conviene a un’oziosa madama fanatica di quel jet set cui appartiene de Winter e nel quale la sua spaurita dama di compagnia si troverà ben presto catapultata suo malgrado.
Instancabile collezionista di celebrità, nel romanzo la Van Hopper tenderà un agguato a Maxim nell’atrio dell’albergo di Montecarlo dove entrambi alloggiano, costringendolo a far la sua conoscenza e fungendo senza volerlo da tramite tra lui e la propria disprezzata dama di compagnia. Indimenticabile il velenoso commiato dopo l’annuncio del matrimonio (“Non crederete mica che sia innamorato di voi?”), con quelle parole che risuoneranno a lungo nell’animo della nuova moglie contribuendo a edificare il massiccio castello d’insicurezza e sfiducia che la terrà prigioniera fino alla rivelazione di lui.
Nel lungometraggio, con una leggera variante, i due s’incontrano invece per caso, mentre lei, che nel film come nel libro ama la pittura e si diverte a disegnare, è intenta a ritrarre un angolo di paesaggio e, scorgendo lui in piedi sull’orlo della scogliera, si spaventa pensando che voglia uccidersi (episodio che invece nel libro avviene qualche giorno dopo il primo incontro). Sostanziale fraintendimento – de Winter in realtà sta rivivendo la tentazione di scaraventare Rebecca sugli scogli provata in quello stesso luogo solo un anno prima – e primo dei molti malintesi che contribuiranno a render tormentata e incerta la storia d’amore tra i due.
And the winner is…: il romanzo della Du Maurier è un assoluto capolavoro. Il film di Hitchcock anche. Pari merito, direi.

