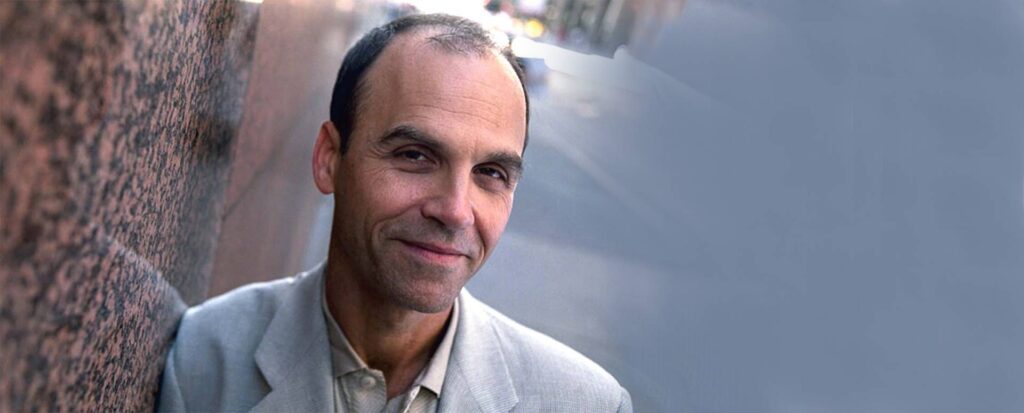Nel 2018 ha pubblicato il romanzo “Il delitto di Agora. Una nuvola rossa” (recensione) per la casa editrice Mondadori. Vincitore del Premio Strega nel 2010 con “Canale Mussolini”. Antonio Pennacchi ha raccontato a Paola Rocco il suo ultimo romanzo.
Nel suo libro Il delitto di Agora ci sono molti livelli di narrazione: episodi di storia antica e favole mitologiche s’intrecciano alla cronaca nera e alla storia contemporanea. Come nasce l’idea di scrivere un libro così?
Premetto che Il delitto di Agora è il mio unico romanzo scritto per così dire a tavolino, scaturito, cioè, dalla testa e non dalla pancia. Io normalmente prima di cominciare a scrivere non butto giù nessuna scaletta, non scelgo a priori ciò di cui parlerò. Però non posso dire d’aver pianificato questa commistione tra storia antica, mitologia e cronaca: è venuta da sé. La storia è sempre presente nei miei libri, il rapporto con quello che precede per me è fondamentale. Noi siamo ciò che siamo stati; i nostri comportamenti vengono da prima di noi. Guardi, anni fa lessi un libro di Piero Angela che mi colpì moltissimo. S’intitolava L’uomo e la marionetta. Nel suo libro Angela sostiene che dentro di noi c’è ancora il coccodrillo… Ne Il delitto di Agora scrivo che la civiltà risale a non più di seimila anni fa, mentre l’uomo è su questa terra da più di due milioni, durante i quali è sopravvissuto a forza di violenza. E questa è ancora presente, anche se la storia un passo di progressione ce l’ha, e pure se a noi oggi sembra di vivere in un universo saturo di violenza dobbiamo comunque ricordare che prima ce n’era molta di più. Oggi può capitare di uscire di casa e uccidere, o essere uccisi. È questione di possibilità, di occasioni. Prima si usciva di casa per uccidere o essere uccisi. La violenza era organica alla società.
Il delitto di Agora rappresenta la riscrittura, con un finale diverso, del suo Una nuvola rossa, uscito nel ’98. Perché ha deciso di tornare a parlare dell’omicidio dei due fidanzati di Cori?
Io spero che gli spiriti dei ragazzi uccisi siano riusciti a trovar pace, in una dimensione ultraterrena. Il nuovo finale del mio libro descrive proprio questo, con quel loro accomiatarsi, quel girovagare trasognato per i vicoli del paese che li videro in vita prima di abbandonare definitivamente questa terra. Ma siamo noi, che restiamo in questa dimensione, a non avere pace, è la nostra ragione che rifiuta di trovar pace. Com’è andata? Cosa è successo realmente? Non lo sappiamo e credo che non lo sapremo mai… L’inconoscibilità del reale è un tema di fondo del libro.
Nel suo romanzo anche la psicanalisi è una presenza importante.
Per me il rapporto con la psicanalisi è un po’ come il rapporto con la storia, è fondamentale dal punto vista proprio cognitivo. Quello con la storia poi forse è stato anche determinato dal mio esser figlio d’immigrati. Come racconto in Canale Mussolini mio padre era umbro, mentre mia madre veniva da Codigoro, sulla riva destra del Po. Poi si spostarono appunto nel Lazio, per prender parte alla bonifica dell’agro pontino. Si sa, gli immigrati non hanno storia: e io fin da piccolo mi sono appassionato alla storia antica, l’ho forse in parte adottata anche come strumento d’integrazione. Tornando alla psicanalisi, io la renderei proprio obbligatoria dai diciott’anni in poi, tipo servizio militare. Anche se è importante rendersi conto che la psicanalisi non può servire a renderci felici. Serve a farci sopportare il dolore del mondo: ci aiuta a reggerlo, a razionalizzarlo.
Grazie ad Antonio Pennacchi per la sua disponibilità.